One-Pointer: la storia di Jeremiah Bonsu - in NCAA nonostante un solo punto segnato all'high school-
La storia di Jeremiah Bonsu, arrivato in NCAA Div.1 nonostante un solo punto segnato all'high school: So che ci saranno degli scettici, ma non è una novità. Per tutta la vita ho dimostrato a questa gente di essersi sbagliata sul mio conto

Nel mio primo anno a Dayton, 2013-2014, sono andato nella nostra palestra, la RecPlex, ogni giorno. E intendo ogni singolo giorno.
Le lezioni erano finite? Di corsa alla Rec.
Venerdì sera? Rec.
Sabato mattina? Rec.
Probabilmente ho trascorso più tempo a giocare a basket che nella mia stanza al dormitorio. E penso che anche altri ragazzi se ne siano accorti presto. Non nel senso di: «Oh, quel ragazzo è davvero forte.» Ma piuttosto: «Ah, quel Jeremia che è giù? È strambo forte. Non esce mai. Non gli piace bere.»
Suppongo avessero ragione. Non volevo bere. Volevo giocare a basket. E se questo mi rendeva strambo, allora mi piaceva essere strambo. Onestamente, non mi importava di cosa pensassero di me tutti quei ragazzi, quando mi vedevano entrare in palestra alle 9.30 di sera in pantaloncini e maglietta.
Cioè, ricordo di aver trascorso il mio primo Halloween al campus – notoriamente una delle maggiori notti di festa a Dayton – da solo nella Rec, dove gli unici suoni in tutta la palestra erano il rimbalzo del pallone e le scarpe sul parquet cerato.
Tutte quelle ore passate lì… continuavo a ripetermi che ne sarebbe valsa la pena. Se c’era una cosa che avevo imparato, era che non devo mai arrendermi. E alla fine del primo anno di college, tornai a casa e continuai ad allenarmi duramente in palestra.
Ottenere una chance di giocare in una squadra di Division 1 era il mio obiettivo, ed ero pronto a tutto per riuscirci. All’inizio del mio secondo anno (2014-15), pochi giorni dopo aver lasciato cv e cover letter all’Athletic Department di Dayton, ricevetti un’email da un graduate assistant in cui diceva che avrei avuto una provino di 10 minuti. Non sembrava granché, ma ero deciso a sfruttarla al meglio.
Al provino, corsi intorno a dei coni, feci qualche tiro e mostrai al graduate assistant il mio ball handling. Al termine dei 10 minuti, suonò il fischietto e mi chiamò a bordocampo. Capii dal tono della voce che non ce l’avevo fatta.
«Ammiro la tua dedizione, Jeremiah» disse, «ma tutti i posti in squadra sono assegnati. Ne abbiamo uno disponibile in panchina come team manager. C’è qualche possibilità che tu voglia accettare quel ruolo?»
Non riuscii a trattenere un sorriso. Cioè, ero triste, ma ottenere un posto in fondo alla panchina suonava come la seconda soluzione migliore per far parte della squadra.
«Sì, lo farò con piacere.»
Prima di andarsene, mi diede un consiglio.
«Porta sempre con te le scarpe da basket per allenarti», disse. «Sono sicuro che vorrai essere pronto a impressionare qualcuno.»
Aveva regione. Gli allenatori mi facevano giocare le partitelle d’allenamento. Ero faccia a faccia con i titolari, chiamavo i blocchi e facevo tante piccole cose per dimostrare la mia attenzione al dettaglio. Alla fine dell’allenamento, restavo lì per pulire e fare un’ulteriore sessione di tiro per un’ora o più.
All’inizio della stagione 2014-15, successe qualcosa di folle. Tre giocatori si infortunarono gravemente chiudendo già la loro annata, e altri due furono allontanati dalla squadra per un incidente fuori dal campo. Rimanemmo con sette soli scholarship players (giocatori con la borsa di studio, ndt).
Me ne stavo seduto in panchina con la palla sul grembo dopo l’allenamento, un giorno, quando Bill Comar, direttore delle basketball operations di Dayton, si sedette accanto a me.
«Hei, Bonsu, ho una domanda per te.»
Mi venne quasi un colpo, ma non dissi niente.
«Sei a conoscenza della situazione in cui ci ritroviamo, continuiamo a perdere pezzi. Che ne penseresti di…»
«Sì!»
Scoppiammo entrambi a ridere.
«Ma se non mi hai neanche fatto finire!»
«Sì! Sì! Sì!»
Stavo per diventare uno walk-on (atleta universitario senza borsa di studio che gioca in un college che concede borse di studio, ndt) dei Dayon Flyers. Tutti i miei sacrifici e il duro lavoro erano stati ripagati.
Niente male per uno che aveva segnato un punto nella sua intera carriera liceale.
Ho sempre amato il basket. Da piccolo non ho avuto possibilità di giocare: la mia famiglia viveva in Newark, New Jersey, e i miei genitori non mi hanno mai permesso di andare al parco. Dicevano che era pericoloso, soprattutto se ci andavo da solo.
Sì, immagino fosse vero, ma dovevo in qualche modo soddisfare la mia sete di basket, e quindi cominciai a seguire l’NBA. Invece di giocare, trascorsi interi pomeriggi e sere incollato al televisore a guardare partite in diretta e in replica.
Tutto cambiò quando ci trasferimmo in Ohio. Avevo 12 anni. Non dimenticherò mai quello che mi disse mia sorella Janice quando arrivammo nella nostra nuova città, Reynoldsburg.
«Jeremiah, guarda tutti questi alberi» disse indicando fuori dal finestrino. «Potrai finalmente fare sport fuori invece di stare in casa a guardarlo.»
Sorrisi.
Pochi mesi dopo, la mia famiglia si trasferì nuovamente: destinazione Pickerington, Ohio. Quando mi iscrissi alla Pickerington North High, la mia priorità era far parte della squadra della scuola. Era il mio sogno. Ciò che non realizzai allora, invece, era che quella sarebbe diventata un’ossessione.
Fui l’ultimo giocatore a essere tagliato dalla squadra quando ero al primo anno. Fui poi tagliato anche dalla squadra riserve. Ma invece di guardare e tifare dalle tribune, decisi di unirmi alla squadra (quella principale, il varsity team, ndt) come team manager.
Non entrai in nessuna delle due squadre neanche al secondo anno, quindi rimasi come team manager. Un paio di giorni dopo i provini, stavo camminando da solo in un corridoio della Pickerington North, quando un tipo comparve all’improvviso.
«Non sarai mai un giocatore di basket. Sei un fallito. Sei un perdente.»
I miei piedi si fermarono. La testa no. «Stai calmo. Stai calmo e basta, dai.»
Le sue parole mi accesero un fuoco dentro. Ero deciso. Non avrei abbandonato il mio obiettivo. Continuai a trascorrere la maggior parte del tempo in palestra, allenandomi con alcuni amici che facevano parte della squadra.
Al terzo anno, credevo di essere migliorato abbastanza da entrare finalmente in squadra. Nei provini feci tutto quello che potevo. Mi tuffai sulle palle vaganti. Parlai molto in campo. Realizzai canestri. Ma i coach mi tagliarono ancora.
Volevo arrendermi. La mia fiducia in me stesso aveva subito un brutto colpo. Non volevo neanche essere più un manager. Arrivavo a scuola e non volevo parlare con nessuno, neanche con i miei migliori amici. Per fortuna, però, loro non me la fecero passare liscia.
Una sera mi chiesero se volevo uscire. Andavano al McDonald’s. Pensai: «McDonald’s? Perché dovremmo andare lì per stare un po’ insieme?» Ma poi si è rivelato che devo molto a quel posto, e che devo ancora di più a quegli amici che erano lì con me.
Arrivammo alle 18.30 e ordinammo. Cinque ore dopo, il mio hamburger era sempre lì, freddo e unto. Grazie al cielo quel McDonald’s era aperto 24 ore. Avevamo trascorso l’intera serata parlando. I miei amici raccontarono barzellette, e mi presero in giro per il modo strano in cui mi stavo comportando ultimamente. Mi fecero sentire normale di nuovo.
Rimasi come team manager, ma ancora più importante è il fatto che mi dedicai nuovamente al mio progetto di entrare a far parte della squadra. Cominciai usando come guida i video di allenamento di J.J. Watt e altri atleti professionisti. Lessi il libro di Jay Bilas, “Toughness: Developing True Strength On and Off the Court”. Mi riconobbi in quello che Mr. Bilas aveva scritto. Cavolo, mi sentivo così bene.
Arrivato l’ultimo anno, diedi tutto quello che avevo. Ma ero nervoso. Come non esserlo? Era la mia ultima possibilità. Dopo i provini, il coach mi fece sedere nel suo ufficio.
«Jeremiah, non possiamo prometterti niente…»
Scoppiai a piangere. Stavo venendo tagliato. Ancora.
«…ma credo che tutti noi sappiamo che meriti di essere in squadra quest’anno.»
Aspetta… davvero?
I miei occhi si illuminarono. Non ero un fallito. Non ero un perdente. Ero un giocatore squadra scolastica, e ne ero dannatamente fiero.
I miei amici della squadra erano rimasti nei paraggi, nel parcheggio esterno, in attesa che la porta della palestra si aprisse. Quando uscii sorridendo, mi corsero immediatamente incontro impazzendo di gioia.
«Evvai! Ce l’hai fatta! È tutto merito tuo! Ce l’hai fatta, Bonsu!»
Non ero mai stato così felice in vita mia.
Chiusi la stagione con un punto a referto. La stagione intera. Un unico punto.
Mi feci il culo in allenamento, ma vidi il campo solo nel garbage time. Ero il giocatore che veniva invocato dai fans nel finale del secondo tempo.
«We want Bon-su!» Clap, clap, clap-clap-clap. «We want Bon-su!»
E quando i coach mi facevano entrare, lo stadio impazziva. Devo ammettere che era davvero divertente.
A dir la verità, non mi importava che i coach non mi facessero giocare. Sapevo di essere un leader silenzioso, facendo delle cose importanti che non compaiono sul referto. E sapevo che avevo tenuto duro fino a realizzare i miei sogni.
Ma sono un tipo competitivo, e una volta che ebbi assaggiato il sapore del successo volli di più. Quando arrivai a Dayton, ero fortemente deciso a entrare in prima squadra, e così trascorsi giorni e notti alla Rec.
C’era un altro ragazzo che veniva in palestra il venerdì e sabato sera. Una volta, quando eravamo solo noi due, mi presentai. Si chiamava Joey, e il suo corpo magrolino e bianco scompariva dentro a una maglietta troppo grande di Michigan State. Aveva anche pantaloncini grigi e… scarpe da corsa. Scarpe da corsa. Cioè, pensai che il tipo fosse uno davvero scarso.
Appena prima che scegliessimo con quale pallone giocare l’uno-contro-uno, altri due ragazzi entrarono in palestra. Decidemmo di fare un due-contro-due, con me a marcare Joey.
Lo scarso in scarpe da corsa mi segnò in faccia 13 punti consecutivi! Mi fece fare la figura dello scemo, ma ammirai il suo ardore. Scoprii poi che Joey era il figlio di Jay Gruden – l’allenatore dei Washington Redskins – quindi immagino che la sua competitività sia comprensibile.
Dopo la partita, io e Joey ci scambiammo i numeri di telefono e ci organizzammo per fare delle sessioni di tiro mattutine alla Rec, quattro o cinque giorni la settimana.
Un giorno dell’aprile 2014, mentre io e Joey stavamo giocando da un po’, entrarono in palestra due walk-ons (ancora atleti senza borsa di studio, ndt) della squadra di basket. I Flyers erano appena rientrati dal terzo turno al torneo NCAA 2014, e i due tipi volevano giocare. Ovviamente, io e Joey non ci tirammo indietro.
Ventuno punti dopo, la partita era finita. Avevamo sbrigato la faccenda rapidamente.
Joey mi guardò da bordocampo, con il sudore che gocciolava dalle sopracciglia, scendeva lungo le guance e poi cascava sul campo.
«Ehi, ce ne dici di provare a entrare in squadra?» (come walk-on, ndt)
Pensavo: «Dannazione, certo!» Ma non volevo sembrare immodesto.
«Sei serio amico? Vuoi davvero provare?»
Nei mesi finali del primo anno e durante tutta l’estate, io e Joey inventammo esercizi per provare a imitare il gioco di Kobe e Dirk. Ci scrivevamo e chiamavamo costantemente per assicurarci che stessimo rispettando il nostro regime. Ci demmo dentro anche in palestra e mettemmo su un sacco di muscoli.
Quando le lezioni ripresero (inizio anno da sophomore, ndt), eravamo pronti a giocarci le nostre chance di entrare in squadra. Consegnai subito il mio cv al basketball office. Joey ce la fece. Io divenni team manager. Pochi mesi dopo, diventammo compagni di squadra. Poche settimane dopo, eravamo in viaggio per il torneo NCAA.
Ce l’ho fatta anche a tagliare qualche retina.
A essere onesti, questa storia non parla di me.
Penso che in fondo questa storia parli dei miei genitori. Vedete, loro vengono dal Ghana. Quando emigrarono negli USA, portarono con sé i loro princìpi ghanesi. In Ghana la formazione scolastica è di primaria importanza. Quindi, a casa nostra, ogni attività extracurriculare era considerata una distrazione.
Il fatto che avessi dedicato così tanto tempo a entrare nella squadra di basket non poteva essere visto di buon occhio da loro. Mia sorella aveva già ricevuto una borsa di studio alla Johns Hopkins University, e penso che volessero che seguissi i suoi passi. Nel momento in cui venni a sapere che ero entrato nella squadra di Dayton, pensai immediatamente a loro. Ero preoccupato per la loro possibile reazione, ma la mia prima telefonata fu comunque a loro.
E poi, si rivelò che non avevo niente di cui preoccuparmi.
Era la prima volta che sentivo mio padre gridare di gioia. Mia mamma scoppiò a piangere. Non so spiegare il perché di quella reazione perché non avevano mai mostrato tali emozioni prima, specialmente per quanto riguarda il basket.
I miei genitori potrebbero non capire mai le ragioni per cui io mi sono innamorato del basket, ma mi auguro che sappiano che questo bellissimo gioco mi ha reso davvero felice. E spero che la mia storia possa essere d’ispirazione a tutti quelli che pensano di arrendersi. Anche un ragazzo che ha segnato un solo punto in tutta la sua carriera liceale può realizzare il suo sogno nel basket universitario.
Si potrebbe dire che mi sono solamente trovato al posto giusto nel momento giusto, che non mi sono davvero guadagnato quel posto. E sapete cosa risponderei? Sì, penso sia vero. Ma dal canto mio ci ho messo una straordinaria mole di impegno e di lavoro per mettermi nella posizione di capitalizzare al meglio la situazione favorevole. Tutto quel lavoro ha portato a qualcosa. E non ho ancora finito di lottare per ottenere di più.
Non ho ancora giocato un secondo (a oggi, 2 dicembre, Jeremiah Bonsu non è ancora sceso in campo nel basket universitario, ndt). Ma so che il mio momento arriverà. Dipende solo da quanto impegno metto nel gioco.
Non sono sicuro che i tifosi dei Flyers canteranno il mio nome quest’anno. Ma voglio che sappiano una cosa: se riuscirò a guadagnarmi un ingresso in campo, darò tutto quello che ho.
Perché è quello che ho sempre fatto.
Il mio obiettivo più grande? Beh, un giorno voglio essere un coach. E non uno qualunque – voglio essere alla guida di un progetto di Division l di altissimo livello. Credetemi, ci metterò tutto l’impegno possibile per raggiungere questo sogno. Non conosco altri modi per farcela.
So che ci saranno degli scettici, ma non è una novità. Per tutta la vita ho dimostrato a questa gente di essersi sbagliata sul mio conto, e non ho certo in programma di smettere.
Traduzione Luca Bellana
One-pointer
di Jeremiah Bonsu, guardia di Dayton University
Da The Players Tribune
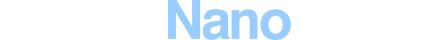










 Occorre essere registrati per poter commentare
Occorre essere registrati per poter commentare

