L’attesa di LeBron James (grazie alla quale otterrà ciò che vuole)
La traduzione di Grantland di oggi riguarda LeBron James e la sua free agency

La traduzione odierne di Grantland di Giacomo Sauro riguarda LeBron James nell'articolo di Jason Concepcion dal titolo "How LeBron James Gets What He Wants by Waiting".
LeBron James si sta prendendo una pausa. Una pausa passivo-aggressiva. Il giocatore di pallacanestro più forte al mondo è un unrestricted free agent per la terza volta in sei anni. Tuttavia siamo diventati in qualche modo così avvezzi al roboante carrozzone del mercato giocatori estivo che quasi non ci rendiamo conto della portata degli eventi. LeBron James, il miglior giocatore del mondo, negli ultimi sei anni, quelli di apice della carriera, si è messo sul mercato per ben tre volte.
Quest’ultima incursione di James nella free agency chiarisce un dettaglio ignorato circa la sua carriera: LeBron fuori dal campo è il giocatore più potente che ci sia mai stato nella NBA. Quello che lo differenzia dagli altri testoni di granito scolpiti sul Mount Rushmore della NBA è il fatto che James è riuscito, grazie a un concorrere di fattori che vanno oltre la normale deferenza tributata a un campione, a trasformare la sua grandezza in influenza. LeBron sta modellando il futuro dei Cavs come nessun altro membro dell’organigramma societario.
I fattori in questione sono questi qui sotto.
1. La grandezza. Se LeBron James non fosse il miglior giocatore al mondo e un prototipo individuale della rivoluzione dei ruoli nella NBA, tutto questo non sarebbe possibile.
2. L’astuzia con cui articola i contratti. Senza la minaccia della partenza un giocatore è solo un dipendente. Nel 2006, a soli 21 anni, James firmò un prolungamento triennale con i Cavs da 60 milioni di dollari con una fatidica opzione per il giocatore per un quarto anno. Se le cose a Cleveland fossero andate bene, perfetto, ma nel caso non gli fosse piaciuto l’andazzo avrebbe avuto una scappatoia che guarda caso sarebbe coincisa con similari clausole firmate da Dwyane Wade e Chris Bosh. Vai con il tanfo di canotte dei Cavaliers date alle fiamme. Dopo “The Decision” James firmò con gli Heat un contratto da sei anni e 110 milioni di dollari. Quel contratto includeva un’opzione di rescissione anticipata non dopo il primo, non dopo il secondo, né il terzo, bensì dopo il quarto anno. Vai con l’acquisto in massa di nuove, non carbonizzate, canotte dei Cavaliers di LeBron James. Questo contratto con i Cavs era annuale con un’opzione del giocatore per un secondo anno, in modo che James avrebbe potuto non solo valutare l’indirizzo della squadra ma anche fare cassa in vista del futuro big bang salariale.
3. L’importanza speciale per Akron, nell’Ohio, e quindi, secondo la proprietà transitiva dei messia di casa propria, anche per la città di Cleveland, con la sua storia sportiva notoriamente tribolata. James che porta i Cavs al titolo esorcizzerebbe decenni di sfortune e karma avversi, ivi incluso il deprimente interregno post “Decision” creato da egli stesso, e scatenerebbe in tutta la nazione un’esplosione emotiva di una forza tale da essere avvertita anche dagli Jedi di galassie lontane lontane. Verrebbero costruite delle statue in tributo, verrebbero cantate delle canzoni in memoria e verrebbero battezzati dei bambini in onore.
4. Il rapporto con l’agente, e amico di vecchia data, Rich Paul della Klutch Sports Group. Nei Cavs Paul ha anche la procura del restricted free agent, nonché rimbalzista personale di LeBron, Tristan Thompson. Molte stelle hanno influenzato la scelta dei giocatori delle rispettive squadre, ma LeBron potrebbe essere la prima superstar a organizzare la propria free agency in parte per far ottenere un contratto a un compagno del supporting cast.
5. L’epica sete di Dan Gilbert per i titoli e le redenzioni dei caratteri. Solo leggendo le parole “Comic Sans” si viene inondati da una marea di ricordi, la maggior parte dei quali variazioni sul tema “Heeey amico, calma!”. L’arringa di Gilbert post “Decision” fu manna per le masse. Tuttavia con il passare del tempo quella lettera non si è dimostrata una gran mossa, e i Cavs l’hanno capito perfettamente, fino a che, solo pochi giorni prima che James tornasse all’ovile, hanno deciso di cancellare dal proprio sito internet quegli strali biliosi marcati con il ridicolo carattere. Un gruppo hair metal veramente terribile una volta cantava “Non sai quello che hai finché non lo perdi”, e nonostante questo la frase resta vera. Gilbert conosce il valore di LeBron, così come sa che aspettarsi che rimanga basandosi solo sul mantra “è impossibile che se ne vada” sarebbe scherzare col fuoco. Quel torrente coagulato di ricordi post “Decision” scomparirebbe in un istante se i Cavs vincessero il titolo, e per questo Gilbert ha deciso di investire molti soldi. Molti molti soldi. Potrebbero addirittura sfiorare il quarto di miliardo di dollari solo in stipendi senza neanche contare la tassa.
Agli occhi del pubblico sono le stelle a portare la colpa, i fallimenti sono i loro, mentre i dettagli minori (gli schemi, le presenze e gli infortuni) si dimenticano in fretta. Ciò che rimane nella memoria è: “Questo qua non ci ha fatto vincere nulla”. LeBron sa bene che è il suo nome quello sul cartellone, a prescindere da ciò che faranno gli altri, ed è per questo che sta forgiando la squadra a modo suo.
Quando LeBron lasciò Cleveland lo fece prima di tutto perché, per quanto potessero essere sgradevoli le ripercussioni di “The Decision”, la potenziale tessera numero 1 del club I Migliori A Non Aver Mai Vinto Un Titolo avrebbe generato effetti di gran lunga peggiori. LeBron doveva decidere se continuare a vendere le scarpe con sopra il suo nome fino al raggiungimento della mezza età o se, una volta terminata la carriera, limitare le prospettive di crescita del suo brand a pubblicità Foot Locker autocommiserative.
È difficile che i giocatori ne escano da vincitori: i proprietari possono gestire le proprie squadre con la freddezza dei calcoli, ma poi evocano concetti come “fedeltà” e “famiglia” per indurre i tifosi a convenire sul fatto che i giocatori dovrebbero accettare offerte minori; tutto questo senza che nessuno rinfacci mai a Dan Gilbert di non metterla mai nel quarto quarto. Non fraintendetemi, ci vuole virtù per accettare meno soldi, ma una virtù che diventa anche ragionevole solo in posti come San Antonio, dove la dirigenza e lo staff tecnico sono evidentemente fuoriclasse del livello dei giocatori che scendono in campo. Non sono molte le squadre a poter vantare un tale ambiente.
La maggior parte dei giocatori pensa in prima battuta a farsi pagare bene. Dopo, quando gli anni migliori iniziano a passare e serpeggia la prima disperazione, cercano di inserirsi in contesti in cui raggiungere quel titolo sfuggente. LeBron ha deciso di bruciare le tappe, consapevole del fatto che un giocatore del suo calibro, arrivato nella lega come il campione predestinato, non si sarebbe potuto permettere di aspettare prima di iniziare a mettersi anelli alle dita. Se James non fosse arrivato al titolo senza dubbio sarebbero iniziate a circolare le voci sul perché quel tale proprietario non avesse mai deciso di spendere abbastanza o sul perché quel tale GM non gli avesse allestito la squadra adeguata o sul perché quel tale allenatore non lo avesse mai impiegato correttamente. Tuttavia questo (se mi si permette l’incursione in un altro campo sportivo) è inside baseball, perché la maggior parte delle persone avrebbe semplicemente detto: “LeBron ha fallito”. Dietro di sé avrebbe lasciato una lunga scia di Michael Jordan in lacrime.
Considerate Wilt Chamberlain. Ha segnato 50 punti di media a partita per una stagione intera, nonché quei leggendari 100 tondi tondi in una singola gara (un salutone ai miei New York Knickerbockers); in più ha fatto sì che la lega cambiasse la forma dell’area. Se vi sembra un curriculum inattaccabile vi scordate dei piedi d’argilla del colosso: se era veramente così forte perché ha vinto solo due titoli? C’è da dire che il buon Wilt ne avrebbe potuto vincere un terzo, se solo Butch van Breda Kolff, l’allenatore dei Lakers, non l’avesse tenuto in panchina gli ultimi due minuti di gara 7 delle finali NBA 1969. Con i Celtics sopra di uno e Wilt che scalpitava per rientrare, pare che Breda Kolff gli abbia detto: “Non abbiamo bisogno di te”.
Questo è quello a cui ho subito pensato quando era uscita la notizia che LeBron avesse messo il veto alle chiamate nelle Finals di David Blatt (allenatore al suo esordio nella NBA). James avrebbe dovuto essere più diplomatico nel suo rapporto con Blatt? Forse. Però nello sport le grandi sconfitte condizionano indelebilmente il modo in cui pensiamo ai campioni. Blatt si sarebbe preso il suo fuoco di critiche, naturalmente, ma sarebbe rimasto nulla più di un aneddoto nella storia del fallimento di LeBron James.
LeBron sta usando il potere che si è creato tramite la free agency per ottenere ciò che vuole. Sta al GM dei Cavs David Griffin capire come far combaciare i pezzi del Tetris e a Gilbert fornire il denaro. Nel recente podcast di Zach Lowe Brian Wndhorst ha detto: “Il modus operandi di LeBron non è mai stato quello di imporre di scambiare questo o quel giocatore o di licenziare questo o quel tizio; lui non è fatto così, ma se decide di giocarsi la carta passivo-aggressiva con la free agency, ossia la sua maniera di esercitare il potere, gli effetti sono imprevedibili”.
E, francamente, LeBron in passato ha avuto un certo successo nel distribuire stipendi e licenziamenti (almeno in un caso) solo rifugiandosi nella free agency mentre aspettava che la sua squadra capisse come renderlo felice. Un saluto a Shabazz Napier e alla sua scelta al draft degli Heat, al nuovo contratto quadriennale da 40 milioni di dollari di Iman Shumpert, a Mike Miller e al suo continuo ruolo di spacciatore emotivo di LeBron e, sospettiamo, al nuovo contratto esagerato di Thompson.
In definitiva LeBron attende. Fino a che, in un modo o in un altro, otterrà quello che vuole.
Traduzione di Giacomo Sauro
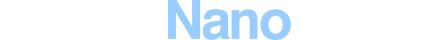










 Occorre essere registrati per poter commentare
Occorre essere registrati per poter commentare

Pagina di 2