La miracolosa quanto inevitabile ascesa al successo di Stephen Curry
La traduzione di oggi di Grantland è di un articolo di Brian Phillips che parla del possibile MVP della stagione, Stephen Curry

Torna la traduzione di un articolo di Grantland ad opera di Giacomo Sauro. Oggi si parla di Stephen Curry, potenziale MVP della stagione regolare NBA. Il titolo dell'articolo di Brian Phillips è "The Rise and Rise (and Rise) of Stephen Curry: The Wildly Miraculous and Quietly Inevitable Success of Golden State’s Point Guard".
Su internet si trovano delle gallerie di immagini della casa, piuttosto imponente, dove Stephen Curry ha passato l’adolescenza, ossia la casa che i genitori fecero costruire nel 1996, l’anno in cui Stephen ha compiuto 8 anni, su un terreno di più di 6 ettari poco distante dal centro di Charlotte, in North Carolina. È una casa grande, ci sono sei stanze da letto. Il padre di Steph, Dell, giocava guardia nella squadra NBA della città, gli Hornets, e un paio di anni prima aveva vinto il premio come miglior sesto uomo dell’anno. Per i Curry era la casa dei sogni, perché se l’erano progettata da soli e avevano fatto arrivare i mobili dall’Africa. Qualche tempo dopo l’avrebbero venduta a un altro giocatore di Charlotte, Gerald Wallace, che l’avrebbe quasi letteralmente tappezzata di schermi TV (le immagini della galleria si riferiscono proprio a quel periodo). Tuttavia si riesce a immaginare come potesse essere la vita dei Curry al tempo, una famiglia benestante illuminata dalla gioia dei figli. Da una parte la cucina dove la madre di Steph, Sonya, attaccava la lista dei lavoretti domestici; da un’altra la piscina dove Steph e Sydel, la sorella più piccola, si tuffavano a bomba; da un’altra parte ancora il campetto da basket sul retro dove Steph battagliava col fratello Seth, esercitava la meccanica di tiro col padre e tirava liberi su liberi fino a quando non rimaneva che il faro a illuminare.
Steph andava a vedere le partite del papà, naturalmente, e girava per il campo durante il riscaldamento; si riescono a percepire i riflessi di quelle esperienze nella tranquillità soprannaturale con cui rilasciava le interviste già quando giocava all’università: aveva la pacatezza e l’impassibilità di chi non trova nulla di intimidatorio nel trovarsi al centro dei riflettori perché è cresciuto esattamente così e perché ha capito presto che nella vita avrebbe voluto giocare a basket. Su YouTube c’è un video del 2002, quando Dell stava chiudendo la carriera a Toronto, in cui uno Steph magrissimo e dall’aspetto quasi elfico (ha 14 anni, è solo un bambino, ma c’è chi già in terza media riceve lettere di reclutamento) racconta alla troupe della televisione dei Raptors, che stava girando un servizio sulla famiglia Curry, che “voleva allenarsi ancora di più... e cercare magari di diventare un professionista”. In quell’anno Steph condusse la squadra della sua scuola media, la piccola Queensway Christian, attraverso una stagione senza sconfitte, segnando 40 o 50 punti a partita. Ma guardate la foto della squadra. Era probabilmente il terzo più piccolo, in una squadra in cui c’era anche il fratello minore. Niente di più distante da un prospetto. La forma mentis era quella ideale per questo sport e in più aveva un’estrema familiarità con l’ambiente, ma non era Peyton Manning; era troppo piccolo, non eccessivamente rapido e non eccessivamente atletico. Dopo il suo secondo anno al liceo dovette ricostruirsi il tiro da zero perché la sua tecnica (la palla partiva dal petto) era inutilizzabile contro difensori più alti e più rapidi. La strada verso la NBA è piena di figli di giocatori che hanno ereditato il sapere dei padri ma non il corpo. Giunto all’ultimo anno, Steph non era stato ingaggiato da nessuno. Virginia Tech, l’università del padre, non era troppo interessata e Steph firmò per Davidson, un piccolo college vicino Charlotte che non vinceva una gara del torneo NCAA da 40 anni.
Questa per me è la cosa più incredibile di uno candidato, da favorito, a vincere il titolo di MVP NBA 2014-15: sembra provenire dal cuore pulsante di questo sport e dal nulla allo stesso tempo. È cresciuto negli spogliatoi della NBA, però è arrivato nella lega dal satellite più remoto del cosmo della pallacanestro. Da quando gattonava ha imparato i segreti del gioco da uno che in carriera aveva il 40% da 3 punti, però la sua biografia è quanto di più lontano ci sia dal profilo del tipico giocatore NBA. Anche sostenendo, con ragione, che lo stereotipo post Hoop Dreams del giocatore che viene dalla strada, viene scelto al draft e compra la macchina alla mamma non rispecchia la diversità delle storie personali degli atleti di una lega in cui Steve Nash e Tim Duncan hanno vinto l’MVP, beh, nonostante questo, Curry è comunque un giocatore che ha frequentato una scuola cristiana e dai principi montessoriani fondata dalla sua stessa madre (e in cui la nonna faceva la cuoca). Steph Curry è uno inserito nel meccanismo ma anche un esterno; una stella la cui ascesa appare tanto miracolosa quanto inevitabile. Se gli avete mai visto tirare una tripla contestata dal palleggio avrete notato che il gioco stesso di Curry denota queste due qualità.
Pensate che al primo anno di Curry a Davidson quasi nessuno sapeva chi fosse. Alla fine del suo terzo anno, quando si dichiarò eleggibile per il draft, gli scout sostenevano che plausibilmente si sarebbe trovato più a suo agio nella NBA rispetto alla NCAA. Capite che il grado di difficoltà di quello che aveva appena fatto, cioè guidare una squadra universitaria di seconda fascia, faceva sembrare meno impegnativo andare a giocare nella lega di pallacanestro più competitiva del pianeta. Proprio così, l’impatto di Steph (lo ripetiamo, snobbato dalle squadre migliori) sul mondo del college basketball fu devastante come l’esplosione di una supernova. Forse vi ricorderete di qualche momento saliente. Nella sua prima stagione fu il secondo tra le matricole per punti segnati dietro Kevin Durant; nella seconda batté il record nazionale di triple in una stagione e portò Davidson, testa di serie numero dieci, fino alle Elite Eight con una allucinante cavalcata vittoriosa. “Allucinante cavalcata” però forse non rende bene l’idea, quindi facciamo così: Steph fece 8 su 10 da tre punti in una vittoria contro Gonzaga, testa di serie numero sette, in cui ne mise 40 (30 nel solo secondo tempo); Steph ne mise 25 nel secondo tempo in una vittoria in rimonta contro Georgetown, testa di serie numero due; Steph ne mise 33 nell’improbabile vittoria schiacciante, 73-56, di Davidson contro Wisconsin, testa di serie numero tre; Steph ne mise 25, quasi la metà dei punti totali della squadra, nella finale regionale, in cui Davidson perse di due contro Kansas, testa di serie numero uno, che avrebbe poi vinto il titolo nazionale.
Non sono soltanto i punti messi a referto. Neanche il fatto che ne abbia messi così tanti quando era sostanzialmente l’unico giocatore di Davidson che gli avversari avrebbero dovuto marcare. È stato vedere il modo in cui lo ha fatto. Questa faccia d’angelo su cui non punteresti una lira. Alcuni giocatori danno la sensazione di poter fare qualsiasi cosa; altri invece no, fino a quando non iniziano a farlo. E quando uno di questi ultimi inizia a sbalordirti con frequenza allora inizi ad aspettarti di rimanere sbalordito; non è forse questo il motivo per cui seguiamo lo sport, per quella sensazione di fede ma anche di sorpresa? Curry non faceva i fuochi d’artificio e i suoi piedi non si muovevano come adesso. Continuava semplicemente a infilare tiri, nella sua piccola bolla di freddezza imperturbabile. Aveva un talento per trovare le fessure, i cunicoli impalpabili che solo i giocatori con un certo tipo di visione audace di gioco sono capaci di vedere. Sfruttava un blocco, tagliava a ricciolo in punta, riceveva la palla, giro sul perno: swish, contro una foresta di braccia distese. Ricezione in angolo, leggera spinta col fianco: swish, mentre il difensore gli passava davanti. Quando non sbagli mai, tutti i tuoi tiri sembrano numeri da campetto. LeBron volò a Detroit per guardarlo giocare, e si alzò in piedi per applaudirlo.
Nell’estate del 2008 Curry era una stella. Partecipò al programma Conan e fu nominato a un ESPY. Non c’era modo che venisse nuovamente ignorato l’anno seguente; gli avversari gli mandavano contro tre difensori più l’autista del pullman ogni volta che toccava la palla. Era così indemoniato che la sua peggiore prestazione statistica di sempre è coincisa con un unicum nel mondo del basket universitario: Loyola concentrò tutte le attenzioni su di lui, lo tenne a secco ma perse di 30 contro Davidson. “Sono laureato in storia; la gente si ricorderà che l’abbiamo tenuto a zero punti o che abbiamo perso di 30?” ha sbraitato Jimmy Patsos, l’allenatore di Loyola, dopo la partita. Quando l’altra squadra si preoccupa più di fermare te che di vincere allora sei una leggenda, qualsiasi cosa segua. Curry fu comunque il maggior marcatore della nazione, con quasi 29 punti a partita di media. Davidson mancò la March Madness in seguito a una sconfitta contro College of Charleston nella semifinale del torneo della Southern Conference. Nonostante questo nessuno batté ciglio quando Golden State decise che un minuto giocatore di un college semisconosciuto sarebbe stata la settima scelta assoluta nel draft del 2009 (prima di Curry furono scelti Blake Griffin, Hasheem Thabeet, James Harden, Tyreke Evans, Ricky Rubio e Jonny Flynn).
Preme sottolineare che, da un punto di vista storico, essere un ottimo tiratore in una piccola università che viene scelto al draft sta al gotha della NBA come l’essere nato nel Medioevo sta al possedere un castello. Curry aveva stravolto la NCAA, aveva distrutto i mobili e poi gli aveva dato fuoco, ma era ancora un semplice tiratore che con le scarpe non superava il metro e novanta; nel migliore dei casi sarebbe diventato uno J.J. Redick (uno specialista che aggiunge una specifica dimensione all’attacco della sua squadra) piuttosto che un Kobe Bryant (un marcatore versatile che supera l’esame del “così forte da essere il protagonista di densi documentari autoprodotti in cui non parla nessun altro”). Suo padre era stato un tiratore, e questo è il massimo che ci si aspettava da Steph; moltissimi giocatori con un profilo analogo al suo non ce l’hanno proprio fatta. Non è corretto dire che fosse diretto verso il fallimento, ma addirittura l’MVP? Il passo verso la Stella Rossa di Belgrado non era poi così lontano.
Ecco un breve riassunto della carriera NBA di Steph Curry.
2009-10: 17,5 PPG, 5,9 APG, 43,7% da 3; secondo dietro Tyreke Evans come rookie dell’anno.
2010-11: 18,6 PPG, 5,8 APG, 44,2% da 3, 93,4% ai liberi; vince la prova di abilità durante l’All-Star Weekend; subisce varie distorsioni alla caviglia.
2011-12: 14,7 PPG (minimo in carriera), 5,3 APG (idem), 45,5% da 3; in seguito a vari infortuni ricorre a due interventi chirurgici; gioca solo 26 partite in stagione.
2012-13: 22,9 PPG, 6,9 APG, 45,3% da 3, 90% ai liberi; batte il record NBA per triple a segno in una stagione; raggiunge i playoff per la prima volta e perde in gara sei contro gli Spurs al secondo turno.
2013-14: 24,0 PPG, 8,5 APG, 42,4% da 3; in quintetto nel suo primo All-Star Game; perde contro i Clippers a gara sette nel primo turno dei playoff.
2014-15: 23,8 PPG, 7,7 APG, 44,3% da 3, 91,4% ai liberi; diventa il giocatore più rapido nella storia della NBA a raggiungere le 1.000 triple segnate (369 partite; il record precedente era di Dennis Scott, che ne aveva impiegate 457); batte il suo stesso record di triple segnate in una stagione; è il giocatore più votato in assoluto per l’All-Star Game; conduce Golden State alla conquista del miglior record della NBA.
Questa traiettoria, se si vuole contestualizzarla, è totalmente assurda e, dal momento che si parla di Curry e Curry esiste in una dimensione in cui l’impossibile e il razionale coincidono, tremendamente naturale. Liscia come l’olio, se vogliamo. È ovvio che dopo due stagioni in cui diventi qualcosa di simile a un caso clinico inizi a riscrivere la storia statistica della NBA, che ci vuole? È come se tutta la sua carriera sia come quel tiro dalla lunga distanza su cui ha fondato tutta la sua carriera: nessuno è capace di segnarlo da laggiù, eppure...
A Davidson gli schemi offensivi di Bob McKillop sfruttavano al massimo i punti di forza di Curry. Allo stesso modo ogni gradino dell’evoluzione recente dei Warriors, dall’ascesa da All-Star del compagno di reparto Klay Thompson all’arrivo di Steve Kerr come allenatore, ha contribuito a favorire Curry; così come anche lo sviluppo generale di questo sport, sempre più legato ai tiri da tre punti, ai tiri liberi e alle spaziature. I vantaggi di sistema però servono solo se poi i tiri continuano ad andare dentro.
Complice della fortunata campagna di Golden State nella stagione NBA 2014-15 è stato il passaggio dall’attacco a metà campo relativamente lento e altamente dipendente dagli isolamenti di Mark Jackson alla nuvola di Steve Kerr. Lo scorso anno i Warriors sono stati la squadra con meno passaggi effettuati di tutta la NBA. Quest’anno eseguono gli schemi, preparano in anticipo il passaggio che seguirà e sfruttano di più Curry quando non ha la palla. I suoi numeri non si sono trasformati radicalmente ma sembra molto più a suo agio nel sistema, il che significa anche che è diventato tremendamente divertente da guardare. Sembra giocare in un sistema tagliato su misura per sé, perché, in effetti, è proprio così (e questo rimane vero anche se Kerry lo fa difendere, cosa che non gli riesce neanche male, per altro!).
È stata una rivelazione. Al college il suo gioco era piacevole anche perché sembrava così alla portata. Non era troppo veloce da non poter essere seguito o così sopra al ferro da sembrare un superuomo; era un ragazzo normale che metteva i tiri che contavano. Ma adesso? Forse esistono delle statistiche avanzate che lo possono confermare, ma a me pare che giochi a un ritmo diverso rispetto agli altri giocatori sul parquet. Riesce ancora a vedere quelle fessure nelle difese, anzi adesso le scorge in anticipo e sa come allargarle. Ora ha un intero repertorio di passetti, virate e finte, tutti movimenti che non richiedono un livello di atletismo sopra la norma ma un controllo e un senso del tempo glaciali. (Dopo la vittoria in gara due dei Warriors sui Pelicans la scorsa settimana, qualcuno l’ha definito “un Kawhi Leonard con la sindrome da deficit di attenzione”, perfetto.) Non è propriamente accessibile, ma in qualche modo è perfettamente lui: un semidio con un piede sulla terra e uno nel cielo che bazzica gli dei dell’Olimpo.
A volte questo contrasto si manifesta. Per buona parte di gara tre di giovedì scorso contro i Pelicans, Curry sembrava monocorde, quasi normale, mentre Anthony Davis, la giovane ala grande di New Orleans, un giocatore così conforme all’idea di divino che potrebbe essere nato dalla fronte della pallacanestro stessa, stava dominando e aveva portato la sua squadra a un vantaggio di 20 punti nell’ultimo quarto. Ma i Warriors hanno cominciato a recuperare piano piano, e quando mancavano 11 secondi sul cronometro Curry ha fatto volare via Jrue Holiday con una finta e ha segnato la tripla del -2. A sei secondi dalla fine, e Golden State sotto di 3, Curry ha sbagliato quello che pensava fosse il tiro del pareggio (in realtà aveva un piede sull’arco), Marreese Speights ha catturato il rimbalzo e gli ha scaricato la palla nell’angolo sinistro. Quattro secondi, i decimi volano via. Uno di quei momenti in cui si può sentire distintamente il proprio battito cardiaco. Due giocatori dei Pelicans, tra cui Davis, gli si tuffano addosso. Una frazione di secondo prima che lo scaraventassero per terra Curry aveva fatto già partire il tiro.
Sapevate come sarebbe andata. Sebbene col senno di poi nello sport siano tutti fenomeni, perché è facile ricordarsi di essere stati certi di una cosa quando in realtà la si è osservata in uno stato di panico sospeso, quello era Steph Curry nel 2015 che si prendeva un tiro all’ultimo secondo al termine di una rimonta straordinaria. Forse non stavate capendo che cosa stava succedendo, forse non ci potevate credere, ma mentre la palla era in aria lo sapevate. La palla si è alzata altissima e proprio mentre Curry era a terra con Davis addosso è passata attraverso la retina. Pareggio e tempi supplementari. Per quasi tutti i 48 minuti Curry non era stato come Anthony Davis, poi negli ultimi secondi è stato Stephen Curry, e gli è bastato. Ha iniziato il supplementare con una tripla, poi Golden State ha vinto 123-119 ed è andata avanti 3-0 nella serie. Nel dopopartita era difficile spiegare esattamente che cosa fosse successo; si poteva dire che aveva giocato Steph, e forse era sufficiente.
Se dovesse vincere il titolo di MVP, come io credo debba, la decisione dipenderà anche dalla gioia che si prova a vederlo giocare. James Harden è efficace come nessuno e Chris Paul è solido come una roccia, ma chi preferireste andare a vedere? Chi vi provoca una sensazione speciale? Perché non dovrebbe essere preso in considerazione questo quando si parla di giocatori al massimo livello di uno sport seguito in tutto il mondo? Tra 20 anni a nessuno batterà il cuore al ricordo delle ottime percentuali ai liberi di Harden. Vi ricorderete della sensazione di attesa per le infinite possibilità disponibili quando Curry si faceva trovare libero e riceveva la palla. Vi ricorderete di quella palla che volava verso il canestro, di come raggiungeva l’apice della parabola e di come già sapevate dove sarebbe finita. Eppure rimanevate ipnotizzati.
Traduzione di Giacomo Sauro
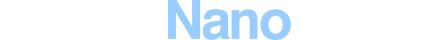










 Occorre essere registrati per poter commentare
Occorre essere registrati per poter commentare

